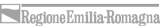Un’intervista sul teatro e sull’architettura
Sofia Nannini | 26/05/2015 | Edarchibo
Archivio Zeta è un’associazione culturale fondata da Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti nel 1999. La loro ricerca è basata sul teatro di parola, sulla riscoperta di testi teatrali antichi, come le tragedie di Eschilo, e contemporeanei, come le opere di Karl Kraus e Pasolini. I loro spettacoli hanno luogo fuori dai teatri, all’interno di architetture e di paesaggi naturali che sono contemporaneamente luoghi di memoria e di riflessione. Edarchibo li ha incontrati per parlare del profondo legame tra le parole e l’architettura in cui esse sono pronunciate.
Il vostro teatro è un teatro senza palcoscenico, dove manca la distinzione netta tra pubblico e attore; come vi adattate a questa assenza, come vi adattate a luoghi pensati per altre attività?
Enrica Sangiovanni: In realtà non ci siamo dovuti adattare ad una mancanza, l’abbiamo cercata. Siccome veniamo dal teatro tradizionale, a partire dalla nostra formazione con il maestro Luca Ronconi, conosciamo bene da dentro le dinamiche del palcoscenico. L’idea di iniziare a fare un teatro che fosse fuori dal luogo architettonicamente preposto alla recitazione ci è venuta perché abbiamo scoperto che ci sono dei luoghi molto belli e importanti, dal punto di vista intellettuale e architettonico, che potevano essere ulteriormente compresi e valorizzati attraverso il nostro lavoro sullo spazio. Portare le persone nei luoghi altri, come il cimitero militare germanico della Futa, Montesole o Monte Battaglia, permette di raggiungere risonanze esponenziali delle nostre parole, grazie alla presenza di un luogo vero e non di una scenografia. Non avremmo mai iniziato il percorso su Eschilo al cimitero della Futa, se non avessimo trovato quel luogo. I luoghi ci parlano, hanno un’identità molto precisa, che spesso non è quella per la quale sono stati pensati. Chi l’avrebbe detto che un cimitero di guerra sarebbe diventato un palcoscenico e teatro? Probabilmente l’architetto che l’ha ideato [Dieter Oesterlen], di cui sappiamo pochissimo, ha pensato a questa potenzialità scenografica. Le proporzioni sono fondamentali; devono essere consone all’essere umano. La prima cosa che facciamo, infatti, quando arriviamo in un luogo di possibile spettacolo, è proprio cercare di capire dove ci troviamo, attraverso linee prospettiche e proporzioni, che ricerchiamo anche nel dialogo con gli elementi naturali.
A questo proposito, l’assenza di elementi di scenografia fissa e strutturata vi impone di aggrapparvi ad altri elementi, come un albero, un tramonto, o anche la musica, che spesso permette di definire la materialità di ciò che state narrando. Come vi rapportate a questi elementi, come immaginate che possano andare costruire quella che Marguerite Yourcenar chiamava “l’architettura tragica del mondo interiore”?
E.S. Sicuramente richiediamo uno sforzo da parte dello spettatore. Il cinema, per esempio, richiede un approccio più semplice, fornendo già tutte le immagini a chi osserva. Quello che a noi interessa è fare in modo che tutti questi elementi riflettano altro; i rimandi sono davvero importanti e ciò che possono evocare. Ad ogni spettatore evocheranno sensazioni differenti, in questo sta la profonda libertà della fruizione del nostro lavoro. Noi proponiamo un punto di vista, da esso ognuno può trarre le proprie considerazioni.
Gianluca Guidotti: Il nostro è un lavoro sui luoghi mitici, di cui parlava anche Cesare Pavese. Il cimitero, la montagna, l’ospedale sono tutti luoghi dove si forma l’immaginario e la coscienza, attraverso una formazione politica e etica dell’essere umano nella società. Il teatro è un mezzo che può far riemergere una possibilità di comunicazione e di relazione tra gli esseri umani; la ricerca di un luogo dove avviene questo incontro e questa relazione è fondamentale. In un teatro, oggi, questa esperienza avviene in modo più banale, da qui la nostra necessità di fuggire da un luogo dove si dà per scontato dove questo avvenga, ma in realtà non avviene quasi più. Il teatro ormai non è più un luogo sacro, mitico, ma un luogo del consumo. Questa urgenza ci ha portati a cercare il teatro fuori dal teatro. Quando leggiamo il Prometeo Incatenato di Eschilo, ci viene in mente la rupe, quindi andiamo a cerca la rupe; quando leggiamo Pasolini e il suo Pilade, che non ha unità di spazio e di tempo, allora possiamo osare dividere questo spazio andando a cercare il parlamento, la montagna, il bosco. In modo analogo, anche per le letture di un romanzo come Le Memorie di Adriano, fatte all’interno di un luogo che noi diamo per scontato, come un museo civico, abbiamo dovuto collocare le parole in un dialogo con le opere esposte.
Non è forse il vostro teatro un modo di restaurare questi luoghi, un restauro non fisico, ma percettivo? Sono infatti luoghi che nella quotidianità sono abbandonati, come il museo civico, come il cimitero dei nemici, come anche le mura di Volterra, che crollano davanti alla nostra indifferenza. Riportare la parola all’interno di quei luoghi permette di averne una percezione diversa, di risignificarli in qualche modo?
E.S. L’idea di portare delle parole su dei luoghi per far cambiare il punto di vista, per farti guardare un luogo in modo diverso, sta alla base del nostro lavoro. Nella quotidianità, non ci si sofferma troppo a osservare com’è fatto un luogo; al contrario, la sosta e il ragionamento sul luogo stesso sono le basi della nostra ricerca.
G.G. E’ un viaggio quello che noi proponiamo ogni volta, che facciamo noi stessi e condividiamo con gli altri.
E.S. Ovviamente, l’architettura ha la capacità di favorire o sfavorire i suoni, la voce. Ci sono dei luoghi nei quali parlare è quasi impossibile. Spesso ci dicono che non usiamo mai i microfoni per partito preso: non è vero. Non abbiamo preclusioni nei confronti né dei luoghi teatrali, né dell’amplificazione; sta tutto nella posizione etica che ci si pone nell’affrontare certi problemi. E’ necessario adattarsi ai luoghi. Spesso, purtroppo, non c’è una presa di posizione etica nei confronti dell’utilizzo di quel luogo, della scenografia che viene costruita e dell’utilizzo del mezzo sonoro. Bisogna porsi il problema; a tutti quelli che ci chiedono come iniziamo a lavorare, rispondo che la prima cosa è porsi il problema di dove siamo, cosa stiamo facendo e perché. Non si può dare per scontato che, se vai in un posto bello, il risultato finale sia bello. Non è così automatico.
Secondo voi, questi luoghi sono rivissuti dagli spettatori dopo l’esperienza teatrale?
G.G. Molte persone ci scrivono perché hanno rivisitato il cimitero della Futa, o hanno riscoperto Montesole. Proprio a Montesole, infatti, abbiamo riattivato percorsi e sentieri che non erano più battuti.
E.S. In particolare, il cimitero della Futa era un luogo sconosciuto e rimosso. E’ un luogo complicato, visto come il cimitero dei nemici. Alcuni ci hanno detto che non avremmo dovuto neanche lavorarci. Il problema è ideologizzare una cosa senza tener conto dell’idea.
G.G. Un giornalista e critico teatrale, Renzo Francabandera, in un’intervista, ha definito il nostro lavoro come la parola architettonica. E’ una definizione molto giusta. Noi cerchiamo luoghi particolari, con un senso rispetto all’opera che stiamo facendo. Ma non si tratta solo di utilizzare questi luoghi come scenografie naturali, è un lavoro sul testo scelto come se fosseun’architettura. Si costruisce un edificio impalpabile attraverso la regia, le battute, quasi ingegneristicamente, come se fosse quel luogo. E’ un lavoro di pesi e contrappesi da commisurare a seconda dell’architettura di parole che si deve mettere in scena. La Futa è un luogo che richiede tempi lunghissimi di comprensione e di messa in scena, per questo abbiamo sempre scelto dei discorsi molto lenti, molto lunghi nel tempo. E’ come se si dovesse costruire la muraglia cinese; abbiamo bisogno di progetti di largo respiro, come l’antichissima Orestea, che ci ha portati a progetti più contemporeanei, come Pasolini, sempre attraverso la mitologia greca. E’ necessario adattare il luogo all’architettura del testo, e viceversa. La parola è un’architettura, nonostante sia impalpabile e muoia nel momento in cui la formuli. Apparentemente non rimane niente, ma quando, per esempio, noi ritorneremo, gli spettatori ritorneranno al museo archeologico, non potranno fare a meno di ripensare alle letture di Marguerite Yourcenar.
Quale progetto, secondo voi, si è meglio adattato al luogo che avete scelto, aldilà del cimitero della Futa, in cui avete recitato moltissimi testi?
E.S. Il progetto che ha sicuramente lasciato un ricordo fortissimo e di cui sappiamo la relativa irripetibilità è il Prometeo Incantenato al Sasso di San Zanobi. Purtroppo alcuni luoghi sono rifuggenti, fanno paura anche agli artisti, perché è difficile approcciarsi. Il palcoscenico, la quinta nera sono una protezione per gli attori; noi siamo, al contrario, completamente esposti. Non c’è il buio, la luce negli occhi dei riflettori. Ma fare teatro vuol dire relazionarsi: Hanna Arendt ha detto che il teatro è il mondo delle relazioni. La stessa cosa riguarda il vostro ambito: l’architettura deve tener conto delle relazioni tra gli esseri umani. Riportare tutto a delle misure umane è importante e non si tratta di una visione antropocentrica, ma naturocentrica; spesso si ha la sensazione di entrare in luoghi non pensati per la vita naturale dell’uomo. Noi che lavoriamo alla luce del sole abbiamo necessità di sapere dove tramonta, questa percezione si perde in molti edifici contemporanei; al contrario, per esempio nel teatro di Segesta, il tramonto del sole sul mare, direttamente in linea con gli spettatori, è un elemento fondamentale.
G.G. Il teatro di Segesta è sicuramente stata una di quelle esperienze che ti fanno capire la relazione profondissima tra teatro, architettura e natura. E’ uno dei luoghi più importanti d’Italia, nonostante il suo abbandono; è un luogo in cui ancora si può recitare senza microfoni né luci, in una dimensione architettonicamente naturale. Lì ancora si percepisce il senso del sacro, che un tempo univa il teatro, l’architettura e l’essere umano, e che purtroppo nella nostra società ha perso significato.
in copertina: foto di Franco Guardascione – Agamennone di Eschilo al Cimitero Militare Germanico del Passo della Futa – agosto 2010
di Sofia Nannini