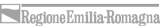La guerra, la vendetta, la democrazia: Orestea al Cimitero militare germanico della Futa
Massimo Marino | 05/08/2013 | Corriere di Bologna / BOblog

La guerra, la vendetta, la democrazia: Orestea al Cimitero militare germanico della Futa
Un grillo, discreto. Una brezza che soffia dai monti, sullo sfondo. Una figura umana si solleva da una coperta, su una porta di consunta lamiera sospesa all’ingresso di un altro campo di lapidi adagiate sulla terra, con nomi di morti di vent’anni o poco più, unbekannte Soldat, Unteroffizier…, il tallone di ferro sulla Linea gotica, i morti delle ultime battaglie, le tombe degli oppressori. Ora un luogo di pace, di meditazione, di memoria di sangue scolorito dagli anni, dove la sentinella della rocca di Argo, levandosi verso il cielo azzurro, con parole reticenti ricorda un’altra guerra, di tremila anni fa, quella di Troia. L’Orestea di Archivo Zeta con la regia di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni, al Cimitero militare germanico della Futa, progettato da Dieter Oesterlen, è un’esperienza unica.
La potete vedere in tre serate, dedicate rispettivamente a Agamennone, Coefore, Eumenidi (con inizio alle 18), scritte dal poeta di Eleusi nel 458 a. C., o ricomposta in un’unica trilogia, che inizia alle quattro del pomeriggio e va a finire nel buio (l’11 agosto: qui il calendario completo). La secca, dura parola di Eschilo risuona, nella bella, moderna, tagliente traduzione di Federico Condello, tra le montagne, senza microfoni, accompagnata da musica fatta di battere di ciottoli, di sfregamento di lamiere, di percussioni, di suoni simili a quelli dell’acqua, del vento, del tuono, inventata in stringente dialogo con le parole da Patrizi Barontini e suonata da Luca Ciriegi e Duccio Bonciani.

Agamennone
La vicenda di Agamennone – che trova la morte per mano del cugino Egisto e della moglie Clitemnestra al ritorno dalla sanguinosa guerra di Troia, e poi la vendetta del figlio Oreste, la sua successiva pena per essersi macchiato del sangue della madre e il giudizio di Atena, che lo assolve con il primo tribunale della storia, dopo un processo assai contrastato dove si fronteggiano le ragioni del matriarcato e quelle del patriarcato – rivive con sensibilità evocativa in questo luogo unico, crinale coperto da più di 30.000 tombe di chi voleva governare con furore il mondo.

Il filo rosso che Clitemnestra e il coro svolgono all’inizio, come segno del fuoco che ha trasmesso la notizia della vittoria dall’Asia Minore alla Grecia, che torna inCoefore come ragnatela della vendetta, è il filo delle violenze e quello fragile della vita in mano a personaggi coperti di bianco squillante o di nero, con parrucche mostruosamente bionde o bianche (Clitemnestra), simili a Parche. I vestiti rimandano a un’antica saga contadina, meno distante di millenni da noi. Le parole, scavate, dilatate, incise nel verso e nel paesaggio, marcano la violenza archetipale dei personaggi, la loro impossibilità di essere diversi, di non compiere ciò che sono trascinati a fare. La guerra domina tutto Agamennone, con immagini folgoranti, nel sacrario centrale del cimitero, che somiglia a una contorta cuspide con ali spezzate raffigurate da pietre di diverso colore, costruzione nibelungica ingentilita da un segno simile a quello delle sognanti architetture wagneriane dell’eretico scenografo Adolphe Appia.

Lo esploriamo, il sancta sanctorum, dall’esterno, da tutti i lati, in uno spettacolo che con lo spazio scrive una poetica, di visione, di rovesciamento, di ingrandimento dei conflitti attraverso la lente della distanza siderale scavata tra personaggi che si dicono frasi che nella nostra vita quotidiana sussurreremmo o urleremmo fianco a fianco. Clitemnestra, in dialogo con il coro, è un sasso bianco che prende vita, tra battere di ciottoli. Dall’altro lato della costruzione, in controluce con il sole, appare Agamennone, su un carretto, con il bottino di guerra rappresentato da una figlia di Priamo, Cassandra. Entrerà nella reggia calpestando un lungo telo rosso, mentre la profetessa amata invano da Apollo canta con parole lontane, incomprese, vaticinanti, la sua profezia, e quel telo si trasforma in flusso di sangue dell’omicidio, mosso dal vento come vela che trasporta e travolge.

La guerra, le sue conseguenze. I morti che ritornano. Agamennone ucciso per vendicare il sacrificio di Ifigenia, la figlia più amata di Clitemnestra, e altri oscuri, lontani omicidi. Un soldato, prima ancora, che torna dal fronte dopo dieci anni, con un cappottone e un elmo pesto, come un milite in fuga da un 8 settembre di sempre. I morti che riappaiono, che parlano, che incombono. Bestie macellate. Come quei giovani dell’ultima leva tedesca, 1944, che giacciono nella collina, coll’odore di nepitella e qualche fiorellino lilla nell’erba profumata.

Coefore
La tragedia prosegue, dopo una pausa, con la vendetta. Oreste arriva sulla collina, con Pilade, guidato da uno spettro, come il suo discendente Amleto (e le portatrici di offerta al morto, coefore, somigliano alle streghe di Macbeth, oltre che a eternamente sconsolate donne in lutto di qualche sud interiore). Ora siamo in un campo del cimitero. La prospettiva tra noi, i personaggi e il fondale costituito dal sacrario è piena di quelle lapidi. Coefore agita un sogno che turba di notte Clitemnestra, quella che ha armato la mano di Egisto: un serpente, nato dal suo ventre, le morde mortalmente il seno, mentre ne sugge il latte. I fantasmi ritornano, e lei cerca di placarli ordinando offerte.

Coefore splende con una processione di donne intabarrate, rumori di grano e di acque, lavacri rituali nell’ampio spazio del cimitero, il lutto inconsolabile di Elettra, la figlia fedele al padre, e la rinascita di Oreste per la vendetta, steso come cadavere nella tomba del padre. E ancora quel filo rosso, di sangue, di stragi, e il campo lunghissimo del colle che si restringe, ancora nel sacrario, nell’uccisione della madre, ora con parrucca bianca, ordinata da una voce profonda che viene dall’interno del monumento, a ricordare la volontà del Dio Apollo. È un abbraccio, il colpo mortale, una dolcissima, feroce pietà. Come tutto questo spettacolo, in cui il vento leggero sembra portare la voce di quei morti, e far ragionare la vendetta antica con tutto quello che successe, “là nei bei monti d’Emilia ove il gran vento / certe volte ne reca assai danno”, come iniziava un poemetto in ottava rima sulla ferocia dei tedeschi e sulla Resistenza nei territori della Repubblica di Montefiorino, scritto da un merciaio ambulante di Vaglie di Ligonchio. Passato. Lontano anche quello. Dimenticato? Come queste tombe, dove si vede una sola foto, molto sbiadita, e qualche sparso fiore artificiale (qualche natalizia Korone, ingrigita).


Eumenidi
Dell’ultimo atto della trilogia ho già parlato altre volte, e rimando a quegli articoli. Qui si entra, per la prima volta nel sacrario del Dio Apollo, che per Eschilo ha ordinato la vendetta. Qui il delitto si discute, non si perpetua con un altro delitto. Sembra ci sia uno scioglimento di quella trama di sangue, di quella macelleria che il luogo rende viva, presente, dolorosamente eccessiva. Sembrano inaugurarsi le regole della nostra (ambigua) democrazia. Le Erinni, persecutrici del matricida Oreste, inconciliabili donne in nero, alla fine accetteranno il verdetto di assoluzione (ma che assoluzione: si può uccidere la madre per vendicare il padre, perché è dal seme di questi che deriva il potere del mondo; i fondamenti di secoli di oppressione della donna). Diventeranno donne, ragazze d’oggi, perse tra di noi, nelle nostre strade, come noi con qualcosa di quel nocciolo antico di dolore, di ferocia, di questioni, inestinguibile.



Il più bello spettacolo dell’anno (accanto al Santo Genet di Punzo)? Non ho dubbi. Qui il teatro rivela ancora la sua forza, che altri provano a annacquare, a modernizzare, con domande domandine e ridicole chiamate di correo al pubblico da villaggio Valtur. Io spettatore qui mi sento davvero straziato da domande, alle quali mi chiedono di rispondere non alzando la mano, come a Santarcangelo, oppure coprendomi con una coperta in mezzo al palcoscenico per poi subito applaudire, senza far nulla, come in Nella Tempesta dei Motus, caricatura ridicola di Paradise Now. Qui le ferite le porterò incise dentro, e non potrò rispondere ma continuare lo strazio della ricerca, perché quello che mi hanno iniettato è l’acido solforico di questioni che mettono in discussione il mio modo di essere un essere umano, con gli altri.

In scena, splendidi, professionisti e non professionisti: Enrica Sangiovanni, Gianluca Guidotti, Marianna Cammelli, Luigia Savoia, Giulia Piazza, Rosanna Marcato, Giovanna Villa, Alfredo Puccetti, Gianni Piazza e Luciano Ardiccioni, che con la sua barba bianca, gli occhi ghiaccio e il volto scavato da rughe e abbronzatura dà corpo alla solennità sacrificale di Agamennone e al tormento del vecchio Oreste delle Eumenidi. Dedicato alla memoria di Franco Belli, professore di economia a Siena, poeta, attore di Archivio Zeta.
Il 13-14-15 agosto si parte da Bologna con un pullman per lo spettacolo, in collaborazione con Bè – Bologna Estate: informazioni e prenotazioni Archivio Zeta
Fotografie di Franco Guardascione