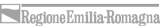Archivio Zeta: ultimi giorni dell’umanità
Massimo Marino | 05/08/2014 | Corriere di Bologna / BOblog

Archivio Zeta: ultimi giorni dell’umanità
Protocollo dell’orrore virato in operetta. Voci rubate alla cronaca, composte in un montaggio intinto nell’indignazione. Esplosione del mondo di ieri attraverso i mezzi di distruzione totale della guerra globale e la forza pervasiva, spettacolare, falsificatoria dei mezzi di comunicazione di massa. Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus è tutto questo, per quasi ottocento pagine. Dalle cancellerie, dai viali di Vienna, dalle redazioni dei giornali, dai bar, dai campi di battaglia della Prima guerra mondiale erompe una tragedia fluviale – preludio, cinque atti, epilogo – che l’autore dichiara concepita “per un teatro di Marte”, perché “i teatri di questo mondo non saprebbero reggervi”. Ci provano a portarla sulla nostra terra gli Archivio Zeta, ambientandola in quel luogo lunare che è il Cimitero militare germanico della Futa, a quasi venticinque anni dalla versione spettacolare che ne diede nel 1990 il loro maestro Luca Ronconi. Ne viene fuori una lacerante, formidabile meditazione sulla guerra e sull’umano, in un lavoro di fenomenale intensità.

Teatro comunitario
Il modo di operare di Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti (Archivio Zeta) l’ho raccontato varie volte (Eumenidi, Edipo Re, La zona grigia, Il nemico del popolo, Eumenidi al Pilastro, Orestea, Iliade, La ferita / Logos. Rapsodia per Volterra). Partono da Pasolini, dalla sua idea di un “teatro di parola”, luogo di dialettica civile sulle grandi questioni che ci tormentano, ci dividono, momento di ricomposizione (di reinvenzione) di una polis assente attraverso l’evocazione di fantasmi lampeggianti dal passato. In loro, l’intento analitico si sposa originalmente con un’attitudine visionaria che parte dallo spazio e crea conflitti, immagini che penetrano, rovesciano, rivelano le parole, le frasi, a loro volta analizzate, scavate, spezzate, fatte deflagrare. Immagine, luogo, parola sono elementi per scatenare cortocircuiti che mirano non a stupire, non a rispecchiare l’attualità e le sue alienazioni, come in certo “teatro contemporaneo”, ma a rivelare la trama dei conflitti che ci agitano in cerca di una (im)possibile coscienza e liberazione, attinte per dialogo, scontro, straniamento, pensiero, emozione.
Quello di Archivio Zeta è un teatro indipendente e di comunità. Si regge economicamente sulle proprie forze e sul pubblico; crea complicità in un territorio appartato sui monti tra l’Emilia e la Toscana, in quel di Firenzuola, portando in scena anche non professionisti, come ama fare un altro dei loro maestri, il regista di cinema e teatro Jean-Marie Straub. Mirano a ricostruire tessuti culturali, ponendo questioni essenziali per la vita comune. Eleggono lo spazio a protagonista, trasformando in reagenti per una meditazione contemporanea luoghi dotati di forte risonanza, come il Cimitero che raccoglie le spoglie dei soldati tedeschi caduti negli ultimi anni della seconda guerra mondiale, 36.000 corpi in una lunga teoria di nude pietre tombali con incisi nomi, date e molte volte la scritta “sconosciuto”, arrampicate lungo la collina con qualche rara, spesso secca, piccola corona funebre e pochi lumini, fino a un sacrario a forma di ala spezzata, intarsiata con pietre di diverso colore.

Nella guerra
Gli ultimi giorni dell’umanità. Macerie e frammenti dalla muraglia di Karl Kraus inizia all’ingresso del Cimitero. Dove ci accolgono due personaggi in marsina, cilindro e pince-nez, che poi si preciseranno come le due figure in continua contrapposizione nell’opera dello scrittore viennese, composta a partire dallo scoppio della guerra e conclusa negli anni Venti. Saranno l’ottimista e il criticone – emblemi non solo di quegli anni, ma icone pronte per raffigurare anche i nostri giorni – a commentare, cercando di vedere, di volta in volta, lo stesso bicchiere abbastanza pieno o totalmente vuoto.
Non c’è misura in Kraus: i materiali tratti dalla cronaca dilagano, si accumulano, diventano beffardi. Il dolore matura a poco a poco, fino a partorire la visionaria danza macabra di un’umanità pronta a disfarsi in una lunga, ignobile, insensata, inesauribile fine. L’idea della guerra come concerto di voci e apparizioni di lemuri, di dannati che ripetono senza speranza di assoluzione gli atti che li condannarono, diventa visione modernissima di un conflitto penetrato profondamente nella cosiddetta pace, adattabile ai teatri bellici dei nostri giorni, dall’Afghanistan all’Iraq alla Palestina all’Africa. Guerra e pace: mai più guerra o pace.

Lo spettacolo è una via crucis, uno stationen drama della banalità che diventa ferocia. Si sale, tra i prati verdi di un’estate piovosa, tra i terrazzamenti a pietra interrotti da croci, tra le file di tombe che rilucono nella luce del sole che si avvia al tramonto e delle nubi su queste vette mosse dai venti.
Si parte con l’attentato di Sarajevo, gli entusiasmi bellicisti, la speranza di vincere in poche settimane, o al massimo qualche mese, con la propaganda, il martellare dei giornali che in poche ore sono pronti a trasformare un albero in manipolazione delle teste. Si sale verso il sacrario. Lampeggiano l’ottimista e il criticone, con i due registi, autori anche dello stringente adattamento, che si scambiano di ruolo, sottolineando la specularità delle due parti nell’immenso blob che siamo diventati.
Vediamo uomini in paglietta, virago della carta stampata che cercano di arrivare più avanti che si può verso la prima linea per dare l’illusione della “diretta”, strilloni, gente che marcia dietro grandi bandiere. La voce stessa di Kraus, e inni, e canzoni di cabaret ci giungono da un apparato montato sulle spalle di un attore: altoparlanti, da processione, che lo trasformano in una specie di robot acustico. Saliamo, per i viali tra le lapidi, e ci sembra di essere sprofondati nelle trincee di quell’altra guerra.
In questa prima parte sentiamo parole che già conosciamo, in fondo. La novità di Kraus, il suo totale irriducibile originale antimilitarismo perde qualche smalto perché dopo di lui ci sono state altre voci contro la guerra, tante, soprattutto in occasione del conflitto del Vietnam. Le sue armi ogni tanto appaiono spuntate per averle troppo sentite.


Reality e trasfigurazione della morte
Tutto cambia nel sacrario. Si parte con una scena scolastica, con bambini alla fame, coperti da fogli di giornale: una maestra cerca di tenerli a bada con il freno della propaganda continua. Poi altre voci, fino al racconto dell’esecuzione di Cesare Battisti, anzi della fotografia che la ritrae. Con il corpo morto circondato dal boia ridente e da gioviali borghesi che fanno a gara per entrare nell’inquadratura. Messa in scena, reality dell’orrore. Pietà l’è morta
E continua a morire mentre si torna nella parte bassa del sacrario, con il corridoio trasformato in una trincea dove sentiamo da soldati sdraiati, da donne male in arnese, disperate, le parole di alcune lettere dal fronte, di disperazione, di paura, di terrore.

Ancora il criticone e l’ottimista punteggiano questa tragedia che in certi momenti si zittisce e lascia la voce al vento, ai profumi della montagna, alla concentrazione. Fino a un grande campo di pietre sepolcrali. A due figure nere. A un lento corteo in campo lunghissimo che avanza con i volti coperti da maschere antigas. Siamo verso la fine del testo di Kraus. Lampeggiano le visioni. La morte, l’orrore, la menzogna di una guerra totale, di un uomo che distrugge la natura, che per il profitto massacra la terra e gli altri esseri umani spacciando la violenza e l’interesse per ideale, per miglior bene comune. Una maschera antigas che porta in braccio una bambola con un’altra piccola maschera è forse la figura più straziante di questa lamentazione dai toni biblici, in cui la parola diventa immagine e l’immagine scava dentro . Silenzio. Dolore. Sguardo non solo sulle trincee, ma sul nostro mondo e sui nostri cuori.

Due corvi in alto, apparizione apocalittica di becchi che si nutrono delle frattaglie umane fornitegli dal Grande Macellaio. Una Voce cala dall’alto, dall’apparato sonoro: da Marte impone all’uomo la fine, per i suoi crimini, per aver ucciso l’umanità. Una fine lenta, come quella finta pace intessuta di guerra, di strazi, di ingiustizia, di menzogna che ancora oggi viviamo e guardiamo su luminescenti schermi, in una infinita danza di morte.

Gli attori vanno ricordati tutti, bambini e adulti, professionisti e partecipi cittadini: Giulia Azzoguidi, Antonia Guidotti, Elio Guidotti, Tommaso Moncelli, Giulia Piazza, Alfredo Puccetti, Andrea Sangiovanni, e i registi drammaturghi Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni. La Voce dall’alto è di Luca Ronconi. Il calzante, incalzante montaggio dei materiali sonori di archivio e gli stacchi atonali, che ricreano il clima degli anni Dieci-Venti del Novecento, sono di Patrizio Barontini.
Si replica alle 18 tutti i giorni fino al 17 agosto al Cimitero militare germanico della Futa. Ingresso euro 20; ridotto 10 euro per under 18; 18 per gruppi pullman e soci Touring Club. Prenotazione obbligatoria: www.archiviozeta.eu, 334/9553640. Da Bologna autobus il 7, l’11 e il 15 agosto al prezzo complessivo di 30 euro (prenotazioni 334/9553640; partenza da piazza Malpighi alle 15.45).

Fotografie di Franco Guardascione